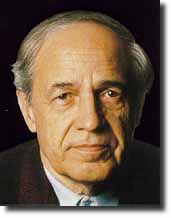a cura di Giulio Mozzi
- gennaio 1997
Corso di scrittura
narrativa a puntate (6)
Le precedenti puntate del
corso di scrittura narrativa hanno trattati questi
argomenti: l'incipit (NAUTILUS, agosto 1996); la voce narrativa (NAUTILUS, settembre 1996); la molteplicità del personaggio (NAUTILUS, ottobre 1996); la redazione dei giochi di ruolo (NAUTILUS, novembre 1996); come si scrive un racconto cannibale (NAUTILUS, dicembre 1996).
In questa puntata
tenteremo di rispondere a una domanda che viene posta
sistematicamente in tutte le situazioni di
"insegnamento della scrittura" (sono arrivati
anche degli e-mail). Questo intervento si propone anche
come punto di partenza per un'eventuale discussione tra
naviganti.
CI SONO REGOLE NELLO
SCRIVERE?
di Giulio Mozzi
"NON CI SONO REGOLE NELLO
SCRIVERE" Mi sono sentito dire questa frase
alcune dozzine di volte: in ogni corso, nei dibattiti che
seguono le conferenze, in molte conversazioni, prima o
poi salta fuori questa frase. Che mi spiazza abbastanza,
soprattutto quando viene pronunciata in un contesto di
corso di scrittura: che cosa sei venuto a fare qui, che
cosa ci fai in un corso, mi vien da dire al
pronunciante, se pensi che non ci siano regole nello
scrivere? In effetti, credo che nei miei corsi non si
parli mai di regole dello scrivere, e comunque si dà per
scontato un concetto minimale di regole dello scrivere:
regole sintattiche, morfologiche, lessicali ecc. (e si
dà per scontato che le regole si possono seguire,
contraddire, sospendere o ignorare deliberatamente: basta
sapere che cosa si sta facendo). Credo di non aver mai
detto qualcosa come: devi fare così, e se non fai
così, è sbagliato. Eppure, prima o poi salta
fuori qualcuno che dice: "Non ci sono regole nello
scrivere". E io, allora, divento una belva.
Fatto sta che questa benedetta
frase salta fuori (durante i corsi) quando si fa lettura
dei testi prodotti dai partecipanti. La lettura ad alta
voce è una parte importante dei corsi: si legge difronte
al pubblico amichevole sì, ma tuttavia vero,
costituito dal gruppo (esperienza impressionante per
alcuni, nuova per quasi tutti), e poi si fanno commenti.
Io (dalla mia posizione di docente, come pensano i
partecipanti, o di servitore, come la vedo io)
cerco semplicemente di rintracciare gli obbiettivi del
testo (anche spingendo l'autore a parlarne) e faccio
un'analisi schematica del testo rispetto ai suoi stessi
obbiettivi. Tizio dice: "Volevo ottenere un certo
risultato" (o Tizio non dice nulla, ma i suoi
intenti risultano da ciò che ha scritto); allora si
cerca di capire con quali mezzi intendesse ottenere tale
risultato, e si cerca di valutare la qualità
dell'impiego, la congruità e l'efficacia dei mezzi
rispetto al risultato; infine si riflette se sia
possibile migliorare la qualità dell'impiego dei mezzi
impiegati e se esistano altri mezzi più congrui e/o
efficaci. Si tratta quindi di un autentico lavoro di correzione,
che si vorrebbe esemplare: se io riesco a far sì che i
miei corsisti imparino a correggere con questa procedura
i loro testi, avrò insegnato loro qualcosa di utile.
Ci sono corsisti che muoiono dalla
voglia di dire di sì al docente (a me), e corsisti che
fanno opposizione pregiudiziale (a me). Che il lavoro di
correzione susciti opposizione, è naturale e proficuo:
innanzitutto perché nessuno è infallibile (io non
faccio eccezione), e poi perché è sensatissimo
difendere le proprie scelte. La discussione tra me
docente e il corsista produce nel corsista stesso,
poiché è costretto a difendere le proprie scelte,
consapevolezza di ciò che fa. Il corsista che mi dice
subito di sì, che ho ragione, è un cattivo corsista (è
anche un corsista dal quale io imparo molto poco).
Probabilmente è una persona che sta spendendo male i
propri soldi, perché cerca di ricevere come un se fosse
un complesso di regole quello che io gli offro, benché
io offra quasi solo delle procedure di lavoro (che sono
sì regole, ma regole di comportamento; non regole di
composizione). Di solito proprio quando mi sto
confrontando con un corsista di questo tipo (ed è
difficile spingere qualcuno a difendere le proprie
scelte, quando costui muore dalla voglia di obbedirti
ciecamente) salta fuori quello che mi dice, e lo dice con
un tono di sfida: "Non ci sono regole nello
scrivere". E io, per l'appunto, divento una belva.
Quello che voglio dire l'ha detto
benissimo un musicista, Pierre Boulez:
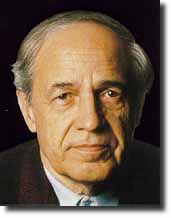
L'invenzione senza disciplina è
molto sovente un'invenzione insulsa, nel senso più
letterale del termine; ma la disciplina senza invenzione
non è meno insulsa, perché non fa presa su nulla. La
difficoltà consiste nel trovare un equilibrio, per lo
meno uno scambio costante, fra questi due poli estremi.
Bisogna possedere in sé l'irrazionale ma nello stesso
tempo mantenere la trascrizione razionale, la sola che
possa render conto del potenziale irrazionale che si ha
dentro. Bisogna che questo elemento irrazionale sia
trascritto in termini razionali perché possa esser
riplasmato da altre persone, che se ne serviranno per
caricarlo a loro volta del loro potere irrazionale
(Pierre Boulez, Per volontà e per caso, conversazioni
con Célestin Deliège, Einaudi, Torino, 1977 (ed.
or. 1975), trad. Paolo Gallarati, p. 65).
Notiamo che Boulez fa uso di due
parole che, in teoria, dovrebbero escludersi a vicenda.
Dice infatti: "un equilibrio, per lo meno uno
scambio costante". Io direi che scegliere uno
scambio costante è tutt'altra cosa che scegliere un
equilibrio; mentre per Boulez pare che l'equilibrio sia
l'ideale, e lo scambio costante un rimedio in mancanza di
meglio. Tuttavia questa parola "equilibrio" mi
puzza un po' da sintesi hegeliana; un equilibrio che
sussuma l'invenzione e la disciplina, l'irrazionale e il
razionale, e ne faccia un'altra cosa, l'opera d'arte I
suppose...
Ma probabilmente (e a giudicare
dalla musica che Boulez fa) qui sto esagerando in
cattiveria. L'equilibrio del quale parla Boulez non è
niente di simile alla sintesi hegeliana: se due cose
stanno in equilibrio, ciò significa che ci sono entrambe
e che nessuna delle due è stata fatta sparire.
L'equilibro e lo scambio costante, quindi, sono
semplicemente due modalità della compresenza di
invenzione e disciplina, irrazionale e razionale. (Da qui
in poi, poiché voglio evitare confusioni con
l'irrazionale, e ho il sospetto che per Boulez, essendo
egli francese, l'irrazionale sia qualcosa di abbastanza
diverso da ciò che è per me, userò un'altra coppia di
termini: l'incontrollato e la disciplina.) Se vogliamo
scrivere un testo che non sia del tutto privo di sale e
che faccia presa su qualcosa, dovremo quindi inventarci
delle modalità di compresenza dell'incontrollato e della
disciplina. Anche per questo Boulez ha trovate delle
ottime parole:
...globalmente, c'è una
disciplina, una direttiva; localmente, c'è
un'indisciplina, una libertà di scelta, di decisione, di
rifiuto (id. p. 66).
Per raffigurare la compresenza di
incontrollato e di disciplina, Boulez usa un'immagine
geografica: quando dice indisciplina locale,
evidentemente ha un'immagine dell'opera come di un luogo,
o di un certo numero di luoghi collocati in uno spazio.
Ma in realtà Boulez, essendo un musicista, ha che fare
(esattamente come i narratori) con opere che stanno nel
tempo. Ora mi domando: questa del "luogo" è
solo un'immagine come un'altra, oppure è un'immagine che
possiamo considerare come particolarmente significativa?
Direi che questa non è un'immagine
come un'altra. Lasciamo perdere che si tratta, da un po'
di punti di vista, di un'immagine banale: banalità e
significatività non si oppongono necessariamente. Boulez
la usa in modo elaborato ed esplicito in un'altra
occasione:
Sovente ho paragonato l'opera alla
pianta di una città: non si cambia la sua planimetria,
la si percepisce com'è, ma ci sono differenti modi di
percorrerla, differenti modi di visitarla. Questo
paragone è per me estremamente significativo. L'opera è
come una città o come un labirinto. Una città è
sovente anche un labirinto: la si visita e si scelgono le
proprie direzioni, il proprio itinerario, ma è più che
evidente che per scoprire una città ci vogliono una
pianta precisa, e certe regole di circolazione (id. p.
55-56).
Qui dal "luogo" passiamo
alla "città" e al "labirinto". Con
una certa brutalità, da queste due parole estraiamo due
significati che ci fanno comodo. Uno: il labirinto è il
luogo dove ci si perde, ossia dove si sta (e ci si muove)
senza percepire il senso complessivo del luogo stesso: il
labirinto, benché progettualmente disciplinatissimo,
appare a chi ci è chiuso dentro come il luogo più
indisciplinato (cioè più incomprensibile) del mondo.
Due: la città è il luogo dove popolazioni diverse e
contraddittorie possono coesistere senza negarsi,
distinte benché sottoposte a una unica amministrazione,
collegate dalle strade e dal sistema dei trasporti,
compenetrate o divise nelle diverse ore del giorno. Se la
città "sovente è anche un labirinto", come
dice Boulez, tuttavia essa è in genere (grazie al cielo)
un pessimo labirinto, pessimo appunto perché non
progettato per essere un labirinto: l'impressione di
labirinticità che la città può dare non è il
risultato di un'accurata progettazione, ma di quella
quota della crescita spontanea della città che non può
essere progettata e gestita (o può essere progettata e
gestita a stento).
Quindi: l'opera è una città,
composta di diversi luoghi, quartieri, reti di
comunicazione, popolazioni; la città è progettata, vale
a dire globalmente disciplinata; tuttavia al suo interno
vi sono zone di crescita (o decadenza) incontrollate; la
presenza di queste zone incontrollate dà l'impressione
che la città sia un labirinto, tuttavia un vero
labirinto è frutto di un progetto disciplinato fino nei
minimi particolari, vale a dire di un progetto senza
indiscipline locali. E' curioso, in sostanza, che per
comunicare un'impressione di irrazionalità (città
caotica) noi usiamo l'immagine di un oggetto in realtà
razionalissimo (labirinto). Possiamo imparare qualcosa da
questa stranezza?
Ci proviamo. Decidiamo (questo è
un partito preso) che ciò che noi vogliamo scrivere,
ciò che è dentro di noi e che preme per uscire, benché
appaia alla nostra consapevolezza come materia bruta,
contenuto informe, irrazionale ecc., in realtà è un
qualchecosa di ordinatissimo. La nostra parte
inconsapevole (così immaginiamo) ha costruito un oggetto
progettato fin nei minimi particolari: solo che questo
oggetto è un labirinto e noi, che ci siamo dentro, lo
percepiamo come incomprensibile. Nel momento in cui
cominciamo effettivamente a scrivere, dobbiamo però pur
dare una forma a questo materiale, affinché sia
comunicabile: allora una forma ce l'inventiamo, la
progettiamo, e la mettiamo su carta: questa forma è la
città, luogo della comunicazione e dello scambio per
eccellenza. Ma mentre scriviamo (o dopo, quando
rileggiamo e ritorniamo sul testo) succede che qualcosa
ci prende la mano. Procediamo in maniera diversa da
quella prevista, facciamo cambiamenti senza preoccuparci
del contesto: mentre lavoriamo a un singolo quartiere o a
una singola via della nostra città introduciamo
particolari non previsti, oppure facciamo proprio qualcosa
di assolutamente diverso. A un certo punto, guardando
la nostra città finita, diremo: accidenti, che caos. In
quel preciso momento, se abbiamo la vista acuta (e se
abbiamo fatto un buon lavoro) potremo vedere, sovrapposto
alla città, ricoprente la città in ogni suo minimo
particolare, il labirinto. Ciò che è caos quando
osserviamo ciò che abbiamo fatto come se fosse una
città, è perfetto ordine quando osserviamo ciò che
abbiamo fatto come se fosse un labirinto. I luoghi nei
quali ci perdiamo quando osserviamo ciò che abbiamo
fatto come se fosse un labirinto, sono luoghi familiari
quando osserviamo ciò che abbiamo fatto come se fosse
una città.
Ci sono quindi regole nello
scrivere? Senz'altro; e queste regole sono ineludibili.
Queste regole ci permettono di far passare tutto ciò che
è sregolato: senza di esse, saremmo muti. Nei miei corsi
uso spesso un'immagine (non particolarmente originale:
amen):
URLO
------------------------------------------------------------------
MANIA
Ai miei allievi dico: quando
scriviamo, stiamo in un campo che sta tra l'urlo e la
mania. L'urlo è l'urlo: l'espressione incontrollata,
prelinguistica, il suono prodotto semplicemente come un
gesto, una cosa del corpo. La mania è il controllo
assoluto, la lingua dalla sintassi standardizzata e
fissa, la corporalità del suono negata. Un esempio di
urlo è l'urlo allo stadio, o il pianto, ecc.; un esempio
di mania è la scrittura legale, la manualistica per
software ecc. Quando noi scriviamo, urlo e mania sono i
nostri confini, a destra e a sinistra. Se cadiamo
nell'urlo, cessiamo di comunicare: diventiamo una sorta
di io/tutti, soggetto archetipico o come dir si voglia,
che non comunica ma si limita ad agire. Se invece cadiamo
nella mania, semplicemente cessiamo di esistere come
soggetto e diventiamo funzione. La pericolosità di ciò
che troviamo al di là di questi due confini non deve
indurci a stare nel bel mezzo: sarebbe una rinuncia
troppo grande (la narrativa di consumo è spesso un buon
esempio di questa rinuncia). Cercheremo un equilibrio,
uno scambio costante.
Le regole nello scrivere vanno
considerate prima di tutto come cose che si adoperano:
cose che di per sé, e prese in considerazione
astrattamente, sono abbastanza prive di senso. Occorre
quindi una certa freddezza nel considerarle. L'ossessione
della regola è deleteria quanto l'ossessione
dell'esenzione dalla regola. Io non credo che abbia senso
parlare di libertà dalle regole. Qualunque
comportamento, se è descrivibile, sarà descrivibile in
termini di sistema, di procedimento, di regole in somma.
Perciò ha più senso parlare di libertà nelle regole.
Si comincia accettando che le regole esistono (per
consenso sociale? sì, per consenso sociale) e subito
dopo si fa un gesto di libertà dicendo: queste regole
sono fuori di me, la mia identità non è fatta di e con
queste regole. Tuttavia poiché (a un primo livello) ciò
che è comune tra me e le altre persone è giustappunto
il complesso delle regole, accetterò di agire
liberamente dentro questo complesso di regole e,
se delibererò di uscirne, comunque agirò liberamente contro,
o in relazione a, questo complesso di regole.
Non si tratta di essere
conservatori, beninteso. Si tratta solo di non essere
autistici. L'autismo è (mi scuso per l'uso improprio che
faccio di questa parola: ma è la parola più negativa
che ho trovata) la malattia latente tra le persone che si
iscrivono ai miei corsi; ed è anche, generalmente, la
malattia latente tra le persone che, nelle più svariate
occasioni, mi cercano o mi incastrano per parlare di
letteratura. (Tra parentesi: le discussioni di
letteratura mi annoiano a morte. Invece parlare di
scrittura, che è tutt'altra cosa, mi interessa; tuttavia
con persone che non siano autistici latenti.) Qui per
autismo intendo: lo scrivere infischiandosene di chi
legge, la dissociazione tra scrittura e comunicazione.
Ecco una piccola tipologia di comportamenti autistici
osservati durante i miei corsi:
- dichiarare di scrivere molto e
non far leggere niente a nessuno;
- non partecipare agli esercizi di
scrittura immediata (in aula) dichiarando di non essere
capaci di concentrazione in una stanza affollata;
- uscire sistematicamente per
fumare una sigaretta quando si fa lettura di testi;
- scrivere tematizzando in
maniera goffa la falsità intrinseca dell'atto di
scrivere;
- accusare i lettori (quindi gli
altri partecipanti) della propria infelicità;
- far precedere la lettura dei
propri testi da dichiarazioni circa gli scopi perseguiti
e i mezzi usati considerevolmente più lunghe dei testi
stessi;
- rispondere ad ogni critica con la
frase: "L'ho fatto apposta";
- scrivere testi nei quali la
scrittura sia esplicitamente paragonata a una delle
seguenti attività umane: vomitare, defecare, buttare la
spazzatura nel secchio (nel cassonetto), masturbarsi,
rubare, realizzarsi, scoprire il proprio sé nascosto,
trovare una dimensione.
L'ossessione dell'esenzione dalla
regola è (secondo la mia esperienza) sistematicamente
collegata all'autismo. Un'amica psicologa (clinica, 12
anni di attività nel servizio pubblico) mi ha detto più
o meno: "Costoro decidono di abbandonare di colpo
ogni regola e non ne hanno la forza (quasi nessuno ce
l'ha); pertanto l'esperienza della scrittura è per loro,
inevitabilmente, l'esperienza di un doppio fallimento:
falliscono perché non sono capaci di agire esenti dalle
regole, e falliscono perché continuano a provare
nostalgia delle regole: pertanto sono sommersi dalla
vergogna e si sentono indegni." Io non so se le cose
vadano effettivamente in questo modo, però i segni di
questo doppio fallimento mi pare di vederli abbastanza
spesso.
Così l'affermazione: "Non ci
sono regole nello scrivere" diventa una specie di
ultima salvezza. Naturalmente chi dice questa frase è
convinto che io reagirò dicendo: "Sì, ci sono
regole nello scrivere", e spera di rafforzarsi (e di
liberarsi dalla doppia vergogna) contrapponendosi a me e
diventando il paladino della libertà che lotta (a nome
di tutti gli altri corsisti, con gratificante
autoinvestitura) contro il maligno Signore delle Regole
(che sarei io). Fatto sta che quando sento dire:
"Non ci sono regole nello scrivere" io divento
effettivamente una belva, ma non perché la cosa in sé
mi faccia imbestialire: perché mi fa imbestialire la
noia. Non ne posso più della ripetizione. Se qualcosa
manderà in malora i miei corsi sarà proprio questo
dover affrontare, praticamente in ogni gruppo, il
partecipante autistico (va bene se ce n'è uno solo) che
rivendica una libertà della quale non sa fare uso e che
mi chiede di aiutarlo a rafforzarsi in una condizione
della quale si vergogna.
Non c'è un comportamento che
garantisca il successo. Come dice qualcuno in un film di
Pedro Almodovar. "E' tremendo stare con una
masochista: non sai mai come farle piacere". Ovvio
che io non ho niente contro queste persone: oltretutto
sono così ben difese che non puoi smantellarle da
nessuna parte. Mi limito a far notare che la frase
"Non ci sono regole nello scrivere" rispetta
tutta una serie di regole della lingua italiana: e chi ha
orecchie per intendere ci pensi su.
Giulio
Mozzi
CHI E' PIERRE BOULEZ. E'
forse il più importante compositore francese del
dopoguerra. Nato nel 1925, frequenta il conservatorio di
Parigi dove studia prima con Olivier Messiaen e poi con
René Leibowiz (dal quale viene introdotto alla tecnica
di composizione seriale). Si inventa (e dirige per anni)
il Domaine Musical, un'iniziativa (cicli di concerti,
conferenze, pubblicazioni ecc.) alla quale si deve in
gran parte la penetrazione della musica contemporanea in
Francia. Durante gli anni del Domaine si forma come
direttore d'orchestra (apprezzatissime in particolare le
sue esecuzioni di Webern e Varèse). Poi si inventa (e
dirige per anni) l'Ircam, l'istituto di ricerche musicali
che ha sede a Parigi sotto il Centre Pompidou. Tra
le opere più importanti di Boulez, citiamo Le marteau
sans maître (su testi di René Char), Pli selon
pli, e le opere più di ricerca come quelle
intitolate Structures e Notations.
Discografia: un cofanetto Erato a medio prezzo
(4509-98495-2) raccoglie in quattro CD tutte le opere
più importanti (dirette in parte da Boulez stesso, in
parte da Daniel Barenboim) tranne Le marteau, che
si può ascoltare in un CD Cbs (serie Masterworks, MK
42619) sempre diretto dall'autore. Boulez ha scritti
molti saggi ed articoli, raccolti in alcuni volumi
pubblicati in Italia da Einaudi: Note di apprendistato,
Per volontà e per caso, Pensare la musica oggi
(tutti, purtroppo, pressoché esauriti).
|