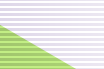|
Per
documentare la storia della scuola in
Italia
Fotografie, libri e progetti che
fanno pensare
Il ‘900 fu secolo di conflitti mondiali e le
guerre entrarono nei sussidiari scolastici
lasciando da parte gli avventurosi calcoli
che si svolgevano nell’ Isola misteriosa
di Jules Verne dove si misuravano le altezze
applicando il teorema dei
triangoli simili.
Due problemi di matematica offrono il senso
di quelle distanze tra passato e presente
che emergono dalla storia della scuola: nel
1919 un ufizialetto supplente alle scuole
elementari propose un quesito: “Un
battaglione decimato dal nemico, composto di
423 unità, è accerchiato in un bosco. Per
nutrirsi dispone di 14 gallette, 71
scatolette di carne, 82 litri di vino, 300
pacchetti di sigarette da 10 l’uno e 640
pezzi di marmellata. Il battaglione
accerchiato non riceverà rifornimenti prima
di tre giorni. Quanto cibo toccherà ad ogni
soldato?”. Il difficile compito fu reso più
complicato dall’intervento di un pestifero
allievo che aveva domandato: “E se qualcuno
fra i soldati muore, come contiamo le
provviste?” Giusto –diceva l’ufizialetto- Il
primo dì muoiono 32 soldati, il secondo 14,
il terzo 102. Come il comandante spartirà le
riserve?”. Fu il ragazzino “a risolvere il
problema, col cumulo delle frazioni,
dividendo i residui di un magazzino in
complicate particelle. Dove avesse imparato
a fare le frazioni nessuno sapeva.
L’uffizialetto aveva ammirato l’ingegno
dello scolaro senza analizzare la sequenza
dei risultati; ma aveva detto che la
soluzione era stata un modello di metodo”
(Neri Pozza, L’ultimo della classe,
Marsilio Venezia 1986, pp. 24-26).
Di ben diversa impostazione fu –nel 1945- la
serie di problemi proposti all’ indomani
della Liberazione: “Per aiutare un compagno
di lavoro fra i 9 operai di un laboratorio
si sono raccolte L. 1125. Avendo versato
tutti la stessa quota quanto ha versato ogni
operaio?”; “Vengono distribuiti in parti
eguali chilogrammi 360 di riso fra 15
famiglie povere. Quanti chilogrammi di riso
toccherà ad ogni famiglia?” (Istruiti,
p.14). L’infanzia fu duramente colpita sia
durante la
Grande Guerra sia nel
secondo conflitto mondiale e assieme
alla gioventù furono coinvolte le
istituzioni scolastiche che dalla metà dell’
Ottocento stavano tentando di combattere
l’analfabetismo.
La storia della scuola è percorso spesso
trascurato, itinerario giudicato di
pertinenza solo dei pedagoghi. Nulla di più
errato.
La storia della scuola è storia della
formazione dei cittadini ed è storia
dell’evoluzione del senso del diritto e
delle istituzioni.
Dietro la lavagna, dai registri di
classe, dai
quaderni, dalle
pagelle, dai
diplomi, dalle carte delle segreterie
delle scuole appare la storia complessa del
nostro Paese.
Quel complesso di documenti, spesso scartato
in modo selvaggio da addetti ignari di una
normativa chiarissima che tutela i
diritti delle istituzioni e della ricerca
storica, nasce dal Regolamento Teresiano
del 1774 che costituisce l’atto formale
di nascita del moderno sistema di
registrazione scolastica (nominativi
allievi, assenze, voti, promozioni) che pone
le premesse della formazione degli archivi
delle scuole (p. 82), tra l’altro il
regolamento asburgico impose l’obbligo
scolastico sino a dodici anni . E storia
della scuola è anche storia delle donne e
del loro irrompere nella vita scolastica
tanto che “Il Popolo d’Italia” scrisse nel
giugno 1924: “Mentre mi duole che la donna
si sia gettata a tutte le scuole frequentate
dall’uomo, per prendere tutti i posti tenuti
dall’uomo, lodo senza restrizioni il
ministro Gentile che, istituendo il Liceo
femminile, ha creato quella che vorrei
definire la scuola d’un sano femminismo,
perché è la scuola quale la natura e la
ragione vogliono” (p. 195 cfr. M.T. Sega,
La scuola fa la storia. Gli archivi
scolastici per la ricerca e la didattica,
Edizioni Nuovadimensione, Venezia 2002). In
realtà non si trattava di
emancipazione femminile il cui cammino
fu irto di ostacoli in tutta Europa e in
particolare in Italia; infatti i
provvedimenti fascisti ridussero i principi
liberali della Legge 17.7.1919, n° 1176
con cui si riconosceva la capacità
giuridica piena della donna, abolendo
l'autorizzazione maritale per gli atti
patrimoniali compiuti e per conseguenti atti
in giudizio o transazioni. Si allargava
allora la possibilità di accedere a uffici e
professioni, come l'avvocatura.
Con il fascismo, l'insegnamento di molte
materie fu precluso alle donne: esse non
poterono accedere ai concorsi pubblici per
insegnare nei licei lettere, latino, greco,
storia e filosofia o per insegnare italiano
negli istituti tecnici. Un Decreto Legge del
5/09/1938, infine impose una riduzione al 5%
del personale femminile, impiegato nella
Pubblica Amministrazione, rappresentò il
culmine della discriminazione sessuale. Solo
con il Regio decreto n° 186 del 1944 fu
eliminato il divieto per le donne di
impartire alcuni insegnamenti e di assumere
uffici direttivi negli istituti di
istruzione media.
La documentazione fotografica e libraria
Qui si illustrano quattro itinerari
fotografici dedicati alla storia della
scuola. Si tratta di percorsi importanti che
evidenziano il tormentoso cammino politico e
istituzionale dell’Italia.
Nello sfogliare le raccolte di questi
documenti che sono stati esposti alla
Biblioteca Nazionale Braidense si può
immaginare che questa ‘galleria fotografica’
sia accompagnata da una voce narrante:
quella della vita dello studente S.
raccontata da Luigi Meneghello in Fiori
italiani, Mondadori, Milano 1988.
E’ proprio S. a ricordare come nel Libro
della quarta classe si presentava
l’infanzia di Mussolini simile a quella di
tutti i bambini: “strappi nel vestito,
ginocchi sbucciati” una vita più rapida ed
eroica giacché è Mussolini a vincere la
Grande Guerra “e in quattro e quattr’otto
abbiamo fatto la Marcia su Roma (Fiori,
p. 30). S. arrivò in quinta dove trovò Il
Balilla Vittorio: è la storia di un
ragazzo che si trasferisce a Roma con la
famiglia e nella capitale avrà il settimo
fratello che naturalmente si chiamerà Romano
e l’anno scolastico di Vittorio illustrava
quello degli studenti italiani che seguivano
Vittorio a vedere le parate, le bonifiche,
la Befana fascista.
A proposito del manuale Il Balilla
Vittorio S commenta: “Il fascismo non è
al centro: è dappertutto... Ciò che risalta
è il brulichio dei saluti fascisti: da
qualunque parti la si guardi la vita
italiana appare fascistizzata senza
residui... l’idea madre è che l’Italia è
civile per natura, ha in retaggio la più
stupenda delle civiltà e il fascismo ne è il
culmine”; del resto Numa Pompilio aveva
presentito l’elettricità e la Regina Madre
era morta ‘consolata dalla Marcia su
Roma’(pp. 31-32). Accadde che, nonostante
l’avversione di Mussolini per ‘i libri’, i
governi fascisti videro un persistente
interesse nei confronti dell’editoria
scolastica.
Le considerazioni di Meneghello sono
comprovate nel catalogo dedicato al periodo
1924-1944 e intitolato: Dalla scuola
all’impero. Sin dal 1923 si applicò la
direttiva di Lombardo Radice che voleva un
libro sussidiario di cultura regionale che
si doveva affiancare al libro per la
traduzione dal dialetto.
Inizialmente nei volumi non c’erano
riferimenti al fascismo e a Mussolini. Anzi
nel testo dedicato alla Campania vi si
leggeva una lode di Benedetto Croce di cui
diceva che “Ha suscitato polemiche,
innalzato il tono degli studi, ha creato ed
alimentato correnti di pensiero, ha portato
un insuperabile contributo di attività, ha
elevato lo spirito del nostro paese”.
In generale in questi manuali si
ritrovavano molti riferimenti di fedeltà
costituzionale e liberale con richiami
storici alla Repubblica Romana e a Mazzini.
Si trattava di una prospettiva
antioscurantista che al governo delle tre ‘effe’
(festa, farina e forca) dei Borboni
opponeva l’amministrazione delle tre ‘ci’
(canzoni, cibo e coltura).
Questi fermenti si spensero nel 1929 con
l’introduzione del libro unico di Stato e
quindi nel 1931 con l’abolizione dell’uso
del dialetto nella stampa e nel 1938 con la
‘cancellazione’ dei testi di autori ebrei.
Maturava la ‘mistica fascista’ che faceva
scrivere: “nelle nostre preghiere
ricordiamo sempre i nostri genitori, il
Papa, il re, il Duce ed i superiori
benefattori della G.I.L. alla quale
apparteniamo”.
Sono gli anni tormentati in cui il
medievista Pietro Silva sostenne -nel 1924-
chi denunciava l’assassinio di Matteotti;
poi nel 1927 lo storico rifiutò di
sottoscrivere un appello per Mussolini
perché intende difendere “alcuni principi di
valore assoluto ed eterno che devono essere
trasmessi ‘intatti’ alle future
generazioni”. Pietro Silva vinse la cattedra
universitaria: nel 1923, nel 1928, nel 1932
e la sua nomina fu sempre annullata per
pressioni politiche. Nonostante ciò Silva
riuscirà a pubblicare nel 1935 il Corso
di storia per i licei. Con altrettanto
coraggio Silva scriverà nel 1946 Io
difendo la monarchia dove scrisse che
“l’errore fondamentale dell’antifascismo” fu
quello di considerare “i fatti italiani fra
il 1922 e gli anni successivi come il
prodotto di una miserabile ganga di
briganti” dimenticando che “quel movimento
ebbe i caratteri di una rivoluzione
popolare” (Istruiti, pp. 99-102).
Una rivoluzione a tratti singolare che
talora esalta il “fascismo liberale,
critico, fenomenologico, antiautarchico”; un
moto che si sarebbe allontanota dalle
discipline militaresche ed avrebbe esaltato
la ‘fantasia’ (Dalla scuola, p. 35).
Non andò così, ma qualcuno ci credette. Si
affermarono la censura e la ‘bonifica
libraria’ e si giunse al libro di testo
unico nelle scuole.
Non fu evidentemente facile intervenire sul
processo di editoria scolastica. Infatti –
nota la Coarelli- nel 1928 fu necessario
emanare un Regio Decreto (n. 780 del
13-03-1928) in cui si affermava che “la
maggior parte degli autori di libri di testo
non hanno avuto una chiara, esatta completa
visione di quello che era il nodo centrale
dell’educazione” giacché “si sono
limitati a dare al libro soltanto la veste e
non anche l’anima fascista” (Dalla
scuola, p. 79).
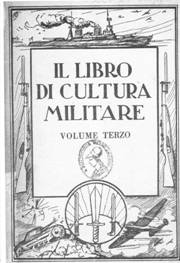 Quel
che serviva lo chiarì il ministro Bottai in
un discorso alla radio (le scuole erano
state predisposte per l’ascolto in ogni aula
di simili trasmissioni di regime); allora
–nel 1937- fu detto che già dalle scuole
medie inferiori gli allievi debbono
possedere nozioni militari (p. 85), allora
si cominciò a teorizzare l’idea di
trasmettere i valori eterni della propria
razza (Dalla scuola, p. 87). Gli
effetti devastanti di una simile propaganda
furono devastanti e ci volle ben più tempo
degli anni della Seconda Guerra Mondiale per
passare
dalla propaganda antiebraica
all’affermazione dei diritti dell’uomo:
ancora nel 1953 un manuale divideva i popoli
“in selvaggi (allo stato di natura),
barbari (semicivili), civili
... gli unici capaci di storia”,
inoltre si elencavano le diverse razze
dell’uomo (Istruiti, p. 53). Quel
che serviva lo chiarì il ministro Bottai in
un discorso alla radio (le scuole erano
state predisposte per l’ascolto in ogni aula
di simili trasmissioni di regime); allora
–nel 1937- fu detto che già dalle scuole
medie inferiori gli allievi debbono
possedere nozioni militari (p. 85), allora
si cominciò a teorizzare l’idea di
trasmettere i valori eterni della propria
razza (Dalla scuola, p. 87). Gli
effetti devastanti di una simile propaganda
furono devastanti e ci volle ben più tempo
degli anni della Seconda Guerra Mondiale per
passare
dalla propaganda antiebraica
all’affermazione dei diritti dell’uomo:
ancora nel 1953 un manuale divideva i popoli
“in selvaggi (allo stato di natura),
barbari (semicivili), civili
... gli unici capaci di storia”,
inoltre si elencavano le diverse razze
dell’uomo (Istruiti, p. 53).
Il tema della guerra era quello che –durante
il fascismo- dava carattere ai testi:
“l’ampia parte fatta alla descrizione delle
battaglie ed alla rappresentazione degli
ordinamenti militari d’ogni tempo, conforme
all’indirizzo militare e guerriero
dell’educazione fascista che ai giovani
d’oggi insegna ad amar la guerra e le armi”
(Dalla scuola, p. 90).
Anche S. ricorda la materia in cui prese ‘nove’:
“E’ una disciplina organizzata attorno alla
nozione che la fanteria è la regina delle
battaglie. Si fanno anche con l’Artiglieria
e i tirapiedi del Genio, ma la regina è lei
con la sua baionetta” (Fiori,
p. 73)
Con ragione Guido Mura (Dalla scuola,
p. 63) mette in risalto come il libro
scolastico ben evidenzi le tendenze
estetiche più vicine ai centri di potere.
Anche se solo una porzione limitata risulta
programmaticamente fascista. Effettivamente
durante il ventennio maturarono opere
editoriali di grande qualità tutte dedicate
all’infanzia: La scala d’oro
dell’Utet e la Biblioteca dei miei
ragazzi della Salani (p. 69). E’ pur
vero che persino i quaderni e le pagelle
furono invasi dalla propaganda fascista. A
guerra finita, ad epurazione completata (le
biblioteche scolastiche furono svuotate dai
testi fascisti che vennero purtroppo mandati
al macero con scarsa sensibilità storica e
anche per questo il fondo della Braidense è
di valore eccezionale) l’editoria scolastica
dovette rivedere i propri cataloghi. Anche
in questo caso si può notare quanto sia
stato lungo il secondo dopoguerra. Ad
esempio l’antologia per le scuole di
avviamento professionale La buona pianta
Zanichelli, Bologna, 1950) insiste
ancora su ‘sentimento e azione’ (Garibaldi,
Silvio Pellico), ‘cuore e mente’ (i Vangeli,
Silvio Pellico), ‘cose e creature’ (Manzoni
e Omero).
Di certo si passò dai titoli che esaltavano
la volonta, l’azione, la forza a manuali che
invitavano ad unire scuola e cantiere, la
vita e il lavoro.
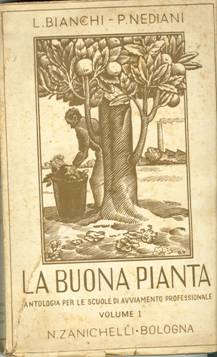 Un reale cambiamento dell’impostazione
grafica del libro di testo arriverà negli
anni ’60 quando “la vivacità viene ad essere
sinonimo di piacevolezza e di modernità, ma
è anche sintomo di una mentalità commerciale
più cosciente e aggressiva, in linea con
forme pubblicitarie programmaticamente
ottimistiche e volutamente gradevoli” (Istruiti,
p. 127). Alcuni stilemi editoriali verranno
cancellati , altri riverniciati; la visione
di insieme è molto simile a quella di una
dissennata edilizia scolastica che oscilla
tra conservazione del passato e arditi
progetti innovativi che comunque non
cancellano l’impressione che le scuole siano
simili a carceri. Un reale cambiamento dell’impostazione
grafica del libro di testo arriverà negli
anni ’60 quando “la vivacità viene ad essere
sinonimo di piacevolezza e di modernità, ma
è anche sintomo di una mentalità commerciale
più cosciente e aggressiva, in linea con
forme pubblicitarie programmaticamente
ottimistiche e volutamente gradevoli” (Istruiti,
p. 127). Alcuni stilemi editoriali verranno
cancellati , altri riverniciati; la visione
di insieme è molto simile a quella di una
dissennata edilizia scolastica che oscilla
tra conservazione del passato e arditi
progetti innovativi che comunque non
cancellano l’impressione che le scuole siano
simili a carceri.
E significative sono le immagini che
riportano gli stili dell’edilizia scolastica
fascista ove “i fasci littori, i
bassorilievi, gli affreschi decorativi, i
mosaici ... concorrono a formare il culto
del Duce” (Fotostorica, p. 60) e così
pure le aule costantemente accompagnate
dalla trilogia iconografica del crocifisso,
del Re e di Mussolini (p. 68). I simboli del
potere invadono ogni dettaglio dei locali
scolastici persino la radio, da cui gli
allievi di Sarmeola ascoltano le istruzioni
per costruire un caro armato, è fregiata
dai fasci littori (p. 95).

Anche l’istruzione agricola è pervasa dal
mito coloniale tanto che gli studenti
disegnano sui prati ‘i possedimenti
d’oltremare’ (p. 98). La progressiva
militarizzazione della scuola con le
organizzazioni dei “Figli della Lupa”, dei
“Balilla” e delle “Piccole italiane” portò
ad adottare per le passeggiate degli scolari
l’ordine di marcia per tre “gloria delle
legioni romane e vanto delle legioni
fasciste”.
Il richiamo all’obbedienza e alla disciplina
traspare da una serie di eserciziari dove si
susseguono i ‘decaloghi’ del fascista e si
esalta continuamente la potenza
conquistatrice dell’Italia (Dalla scuola,
p. 89) e i libri si riempiono di motti
imperativi, di sintesi, di oratoria del
regime che esalta il passato e il futuro
imperiale. Così S. ricorda il classicismo
dell’Era Fascista: “Dante era ammirevole
perché scriveva cose, e il Petrarca perché
scriveva parole. Il Carducci era maschio, il
Pascoli femmineo: bravi l’uno e l’altro.
Tutti sono da pregiare per qualche motivo.
Nel caso del Tasso è un grande squilibrio,
in quello del Manzoni un grande
equilibrio... Un po’ ossificata era la
storia... Libri e insegnanti di storia non
facevano mai sentire che tutto ciò che c’è
stato è stato un processo... Mancavano
Darwin, la cosmologia, Marx e Freud” (Fiori,
pp. 87-91). Era tutto un propagandare le
“idee” ufficiali annotava S.
E il simbolo della rigidità,
dell’autoritarismo nella scuola è la foto
che ritrae un intera classe che ha
trasferito banchi e lavagna sulla spiaggia
(Jesolo?): gli allievi in grembiule bianco
con le braccia ‘legate’ dietro la schiena
osservano una lavagna nera e un’insegnante
nera mentre la duna copre la vista del mare
(Fotostorica, p. 101). Un’immagine
‘pasoliniana’ che trasmette timore che fa
aspirare alla libertà di insegnamento e di
apprendimento.
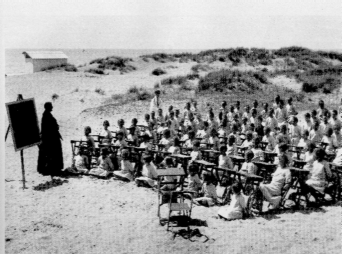 La costrizione di quegli studenti è quella
stessa in cui si venne a trovare lo studente
S. che imparò dal ‘maestro Toni’ (Antonio
Giuriolo morto partigiano a 32 anni) la
religione della libertà perché “senza di
essa non c’è alcuna società (come non c’è
alcuna vita privata) che valga la pena di
avere. E S. ricorda come l’amico Franco
scrisse la parole per una piccola lapide
dedicata al ‘maestro’: In tempi servili /
qui cercava rifugio / nella storia e nella
poesia / qui nell’attesa / insegnava la
dignità del cittadino / Antonio Giuriolo /
partigiano medaglia d’oro / cresciuto e
caduto per la religione / della libertà. La costrizione di quegli studenti è quella
stessa in cui si venne a trovare lo studente
S. che imparò dal ‘maestro Toni’ (Antonio
Giuriolo morto partigiano a 32 anni) la
religione della libertà perché “senza di
essa non c’è alcuna società (come non c’è
alcuna vita privata) che valga la pena di
avere. E S. ricorda come l’amico Franco
scrisse la parole per una piccola lapide
dedicata al ‘maestro’: In tempi servili /
qui cercava rifugio / nella storia e nella
poesia / qui nell’attesa / insegnava la
dignità del cittadino / Antonio Giuriolo /
partigiano medaglia d’oro / cresciuto e
caduto per la religione / della libertà.
La terz’ultima e la penultima parola già
incise sulla lapide furono cancellate per
disposizione del sindaco in base
all’argomento che di religione ce n’è una
sola; e pare che Franco furibondo abbia
tentato invano di sostenere che quella
invece è la mamma. In verità il sindaco non
era uno sciocco, e quando Franco si fu
calmato, gli fece capire che la “religione
della libertà” era un’espressione
giustissima, ma inopportuna. E’ un
tipo di argomento che in altri contesti è
ancora molto usato in Italia. Forse la
verità è sempre inopportuna” (Fiori,
pp. 168-169).
Sono immagini che fanno tornare alla memoria
un’Italia contraddittoria quella dei versi
di
Luigi Tenco che –nel 1962- in Cara
maestra cantava: “Egregio sindaco / mi
hanno detto che un giorno / tu gridavi alla
gente / ‘vincere o morire’. Ora vorrei
sapere come mai / vinto non hai eppure non
sei morto / e al posto tuo è morta tanta
gente / che non voleva né vincere né
morire”.
Gli anni del dopoguerra richiedevano
urgentemente la trasformazione della scuola
da strumento di propaganda del regime a
momento di educazione all’autonomia e alla
libertà: già il 21 agosto 1945 furono varati
i nuovi programmi della scuola elementare e
nel frattempo era al lavoro la commissione
per la ‘defascitizzazione’ dei libri di
testo; inoltre il Governo Militare Alleato
chiese la sospensione dal servizio di quei
docenti che, tra l’altro, erano stati
delatori di colleghi e studenti (Istruiti,
p. 138). Nel complesso il lavoro delle
commissioni regionali per i libri di testo
fu difficile e contraddittorio e i nuovi
manuali di storia affrontarono con molta
esitazione come documenta molto bene la
Coarelli la spiegazione del fascismo e del
nazismo, talora indulgendo a frasi elusive
quali quella per cui: “fu appunto la
folle politica d’isterismi, caldeggiata da
dittatori di poca coscienza e di scarso
equilibrio, quella che travolse le dittature
e con esse purtroppo anche i popoli” (Istruiti,
p. 148). Dittatori di poca coscienza? Nel
1949 sembrava esser ancor radicata l’idea
che vi fossero dittatori con tanta
coscienza! Iniziava così un lungo dopoguerra
estremamente cauto nell’affermare le
‘verità’ della storia del ‘900.
I segni della
reticenza che tuttora perdura
nell’organizzare una scuola che educhi alla
religione della libertà sono dati dalla
perdurante assenza di autori come
Nuto Revelli che ricordava: “Nel luglio
del '42, con il V reggimento alpini della
divisione Tridentina, fui inviato sul fronte
russo. Conservo un ricordo preciso di quanto
fosse immensa la mia ignoranza. Appartenevo
alla categoria dei cosiddetti "colti" ma a
malapena sapevo dove fosse collocata
geograficamente l'Urss. Non mi rendevo conto
di appartenere a un esercito di aggressori.
I tedeschi vincevano anche per noi e li
consideravo alleati preziosi. Andavo a
migliaia di chilometri da casa mia, ad
ammazzare o a farmi ammazzare, ma per che
cosa? Per la "Patria". Quale "Patria"?
Quella del fascismo, della monarchia, dei
Savoia?”.
Assente anche
il testo di don Lorenzo Milani
L'obbedienza non è più una virtù
anch’egli ben determinato nel testimoniare
com’era stato ingannato a scuola: “Ci
presentavano l'Impero come una gloria della
Patria! Avevo 13 anni. Mi par oggi. Saltavo
di gioia per l'Impero. I nostri maestri
s'erano dimenticati di dirci che gli
etiopici erano migliori di noi. Che andavamo
a bruciare le loro capanne con dentro le
loro donne e i loro bambini mentre loro non
ci avevano fatto nulla”.
Assenti
spesso, quasi sempre, le Dichiarazioni dei
Diritti dell’Uomo così come la storia della
Convenzione di Ginevra che ieri fissava
l’obbligo (evidentemente ancor oggi
disatteso) di illustrarne il testo a tutti i
militari e oggi dovrebbe essere diffusa in
tutte le scuole.
L’interessante storia dei libri scolastici
illustrata dalla Biblioteca Nazionale
Braidense si ferma al 1953 e si auspica che
questo lavoro prosegua documentando
iniziative coraggiose e piccole e grandi
miserie culturali che perdurano ancor oggi.
Già nel 1953 un libro riportava tra i vari
stili epistolari un modello di lettera di
raccomandazione: “... Il latore della
presente è un mio caro amico. Egli ha
bisogno di Lei, ed io glielo raccomando
vivamente, pregandola di ascoltarlo e di
accontentarlo. Farà del bene ad un cuore
buono e riconoscente; io pure le sarò
infinitamente grato” (Istruiti, p.
55). E ancor oggi non mancano segnali
inquietanti: un’antologia commenta i versi
che Umberto Saba dedica al padre che lo ha
abbandonato sottolineando come la razza
(sic!) ariana e quella ebraica siano da
sempre rivali; un altro manuale mette sullo
stesso piano i satanisti con i Buddisti e i
Testimoni di Geova. L’affermazione di una
società che non discrimini è difficile e può
solo avvenire attraverso la redazione di
libri di testo che invitino al rispetto di
tutti con coraggio senza farsi prendere da
pedagogie dell’opportunismo.
Documentare
la storia della scuola italiana è oggi
inopportuno?
Forse si, forse è questo il motivo per cui
si fa tanta fatica ad accedere alle raccolte
degli archivi scolastici, forse è per questa
ragione che ancora oggi molti istituti
scolastici non riversano agli Archivi di
Stato i loro documenti storici. Eppure
l’importanza di queste ricerche appare
anche dalle
Fonti per la Storia della Scuola curate
dall’Archivio Centrale dello Stato. Si
tratta di fonti rilevanti che testimoniano
le fasi storiche del nostro Paese anche nei
confronti dei minori ‘devianti’ obbligati a
frequentare le
scuole carcerarie anch’esse ricche di
archivi. Questo tipo particolare di
istituzioni scolastiche fu oggetto di
particolari interventi all’indomani della
Liberazione.
Infatti la ricostruzione investì anche i
centri di ‘rieducazione’: le carceri
minorili, i Monelli banditi. E nel
1951 il Ministero di Grazia e Giustizia
promosse una serie di riprese fotografiche
per combattere l’ “ingiusta e denigratoria
campagna di stampa” (p. 22). L’
Istituto Nazionale Luce documentò come
i ragazzi fossero trattati bene e quei
documenti ora sono stati salvati grazie alla
collaborazione sviluppata tra archivisti e
Ministero della Giustizia.
 Questo materiale è stato studiato
dall’Archivio di Stato di Roma che annota
come “
lo sforzo dei fotografi però, non ha
potuto nascondere, anzi ha contribuito ad
esaltare l’impressione di vuoto, vastità e
squallore degli ambienti” (p. 23). Questo materiale è stato studiato
dall’Archivio di Stato di Roma che annota
come “
lo sforzo dei fotografi però, non ha
potuto nascondere, anzi ha contribuito ad
esaltare l’impressione di vuoto, vastità e
squallore degli ambienti” (p. 23).
Gli scenari della giustizia minorile in
Italia ci riportano ai fallimenti del
sistema educativo totalitario: “alla fine
del secondo conflitto mondiale l’Europa era
popolata da milioni di ragazzi e bambini
oppressi dalla povertà. L’Italia era fra i
paesi più colpiti: un paese povero con tassi
di analfabetismo e disoccupazione
elevatissimi. Nel 1947 la popolazione d'età
minore di 15 anni costituiva oltre un terzo
della popolazione totale del paese e il
tasso di mortalità infantile si attestava
intorno al 72,2 per mille. Adulti e bambini
erano costretti ad arrangiarsi e vivevano di
espedienti, cercando di approfittare, non
sempre legalmente, delle risorse materiali e
finanziarie che avevano iniziato ad affluire
subito dopo la liberazione ad opera delle
forze anglo-americane.
Le distruzioni lasciate alle proprie spalle
dall'esercito tedesco durante la drammatica
e lunga ritirata riguardavano anche il
patrimonio edilizio dell'Amministrazione
penitenziaria.
Ad Avigliano gli Alleati nel corso della
loro avanzata avevano insediato il proprio
quartier generale e i ragazzi erano stati
trasferiti in sedi di fortuna; a Roma il
bombardamento del luglio 1943 aveva colpito
l'Istituto di rieducazione "Aristide
Gabelli" situato nel popolare quartiere di
S. Lorenzo e i minori evacuati erano stati
tutti concentrati presso l'antico Carcere di
S. Michele; più a nord, i centri di
rieducazione per i minorenni di Ancona e di
Cairo Montenotte in provincia di Savona
erano stati distrutti.
Il Ministero di Grazia e Giustizia si
trovava così ad affrontare una duplice
emergenza, con l'aumento della popolazione
ricoverata e la concomitante indisponibilità
di molte strutture. Nel 1946 Vittorio De
Sica, attraverso le riprese dal vero del
Carcere minorile romano di S. Michele, nel
film Sciuscià denunciava non solo le
pessime condizioni materiali di vita dei
ragazzi nei riformatori, ma soprattutto la
crudeltà e le pratiche distorte che
caratterizzavano il trattamento a cui
essi erano sottoposti.
Il passaggio da un sistema autoritario come
quello fascista a quello di uno Stato
democratico aveva messo in crisi l'ideologia
prevalentemente repressiva sottesa al
sistema della giustizia minorile fino ad
allora e aveva aperto la strada all'idea di
rieducazione. Il concetto di
"disadattamento" alle norme sociali che si
sostituiva a quello di "traviamento"
comportava un'attenzione completamente
diversa per la personalità individuale del
giovane sottoposto a trattamento.
Tra il 1951 e il 1962 fu varata la completa
riforma della giustizia minorile
caratterizzata dal decentramento
amministrativo, dall'incardinamento del
servizio sociale all'interno del Tribunale
per i minorenni e del Centro di
rieducazione, dall'introduzione negli
istituti delle figure specializzate dell'assistente
sociale e dell'educatore” (p.25).
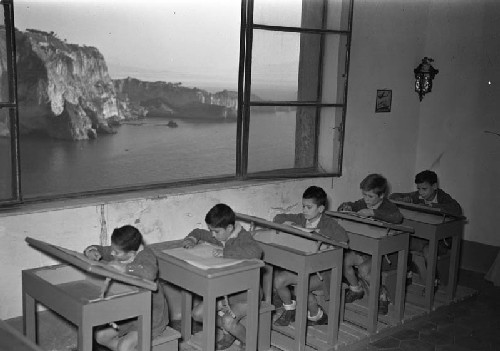
Nisida-Centro di rieducazione dicembre 1951
(Monelli p. 61)
Allora l'istruzione scolastica aveva la
finalità di rendere il ragazzo consapevole
dell'errore commesso "disertando la via del
dovere" e del modo in cui poteva ritornare a
vivere degnamente nella società. Molti
ricoverati erano analfabeti o semianalfabeti
e presentavano quasi sempre una carriera
scolastica irregolare, con precedenti
disciplinari. Per loro l'istruzione
elementare impartita all'interno degli
istituti era obbligatoria e i certificati di
studio erano rilasciati senza alcuna
indicazione o accenno alla casa di
rieducazione nella quale erano stati
conseguiti. In alcune sedi erano istituite
sezioni per studenti di scuole medie, oppure
i ragazzi frequentavano le lezioni presso le
scuole pubbliche. Si tenevano anche corsi di
lingue straniere, di musica, di canto, di
disegno. A Bologna, per esempio, il corpo
bandistico della Casa di rieducazione teneva
concerti in pubblico, eseguendo anche musica
classica e brani d'opera.
In alcuni istituti esistevano sezioni per i
ragazzi che avessero mostrato una
eccezionale tendenza allo studio delle belle
arti, del canto, della musica e della
recitazione. Presso ogni casa di
rieducazione era istituita una biblioteca
con sala di lettura e servizio di prestito.
"Si utilizzavano le tecniche della didattica
moderna ispirate ai principi
dell'individualizzazione
dell'insegnamento..." - ricorda la signorina
Angiolina Freda, maestra elementare con
oltre quarant'anni di insegnamento nelle
istituzioni minorili - "...la scuola, pur
seguendo i programmi delle scuole pubbliche,
si differenziava da quella tradizionale che
adoperava il libro di testo, l'abbecedario,
la penna e il quaderno. La didattica attiva
si applicava a tutte le materie e consisteva
nel partire da una forma di sintesi per
arrivare all'analisi; il ragazzo veniva a
contatto direttamente con la natura,
piantando semi, vedendo spuntare le piante
nell'orto. Molti istituti usavano il
giornalino per rispondere ai bisogni dei
ragazzi non sempre compresi".
Il lavoro era riconosciuto come mezzo
rieducativo di primaria importanza, al quale
venivano avviati tutti quegli allievi che
non frequentavano la scuola. Era distinto in
lavoro agricolo o lavoro industriale.
L'addestramento dei minorenni veniva
ripartito in corsi che comprendevano i
seguenti indirizzi: corsi per fabbri
meccanici, corsi per falegnami-ebanisti,
corsi per calzolai, corsi per intagliatori
in legno, corsi per sarti e corsi di
agraria. Il lavoro dava al ragazzo fiducia
in se stesso e nelle sue capacità. Nelle
case di rieducazione femminili l'istruzione
professionale era volta essenzialmente
all'insegnamento dei lavori "donneschi", di
sartoria, di ricamo, cucito, stireria,
maglieria (Monelli, pp. 57-58).
Il problema della ‘rieducazione’ dei
minori non imputabili è ancor oggi di
grande rilievo come testimoniano i “Quaderni
del Centro Nazionale di documentazione e
analisi per l’infanzia e l’adolescenza” n.s.
2003; così la Randazzo evidenzia: “I
dati raccolti confermano che il percorso di
emarginazione della devianza minorile parte
dalla famiglia, sempre più disgregata e
assente, passa per la scuola, incapace di
accogliere la diversità e il disagio del
minore espressi in atteggiamenti aggressivi
e inosservanti di qualsiasi regola, finisce
sulla strada e sulle piazze dove spesso i
ragazzi si riuniscono in bande per trovare
nel gruppo dei pari quel sostegno e quelle
certezze che gli adulti hanno loro negato.
È infatti emerso
dalla ricerca che è proprio nei luoghi
pubblici che vengono commessi dai minori non
imputabili la maggior parte dei reati e che
gli stessi agiscono in concorso con altri
minori non imputabili e quasi esclusivamente
in danno di adulti, segno che la loro
condizione di abbandono a sé stessi e la
mancanza di positive figure di riferimento è
spesso determinante per la commissione di
illeciti (p.7)”.
Su questi temi è
intervenuto con efficacia
Vittorino Andreoli che denuncia come si
sia “passati da un rigore tecnicistico del
sistema educativo del passato (si pensi al
ruolo distaccato e assente dei padri),
all’attuale anarchismo, in balia degli
umori. ... Senza autorità e senza coerenza
si favorirà l’etica della circostanza, per
la quale ogni comportamento è sempre
possibile dipende da quando e come” (Voglia
di ammazzare, pp. 234-235). Stridente è
il contrasto tra l’imparare a pensare e
l’essere obbligati a non ragionare; ancor
oggi –nota Andreoli- “si fa confusione tra
educare e dominare ...”, l’uomo che pensa è
l’antitesi dell’uomo presente e si è
arrivati al punto “di far apparire
l’intelligenza un difetto o comunque una
caratteristica dannosa al vivere d’oggi” (p.
263).
E queste contraddizioni già le avvertiva lo
studente S.: si stava formando una nuova
idea dell’Italia e questa “veniva a toccare
la cultura scolastica e la struttura della
mente di S. in tutta una serie di punti
critici, e in ciascuno di questi l’effetto
era esplosivo. Per la prima volta gli pareva
di pensare e si sentiva pensare.
Se in principio gli avrebbe fatto spavento e
ribrezzo l’idea di poter diventare
‘antifascista’, ora quel sentimento
s’invertiva, e alla fine sarebbe inorridito
di essere ancora fascista. Fu un processo
esaltante e lacerante insieme: un po’ come
venire in vita e nello stesso tempo morire”
(Fiori, p. 183).
Un processo che nella vita della nostra
scuola avvicenda, ancor oggi, vecchi e nuovi
integralismi. E proprio per superare l’idea
di una scuola autoritaria è necessario
studiare il passato delle nostre istituzioni
scolastiche così come sta accadendo per la
scuola media di Vicenza che, non a caso, si
chiama Antonio Giuriolo.
Piero Morpurgo
R. Coarelli, ed., Dalla scuola
all’impero. I libri scolastici del fondo
della Braidense, edizioni
VIENNEPIERRE, Milano 2001
R. Coarelli, ed., Istruiti e laboriosi
gli anni della ricostruzione. I libri
scolastici del fondo della Braidense
(1945-1953), Viennepierre edizioni,
Milano 2004
P. Sardellini, A. Ciaschi, M. Calzolari, L.
Oggianu, edd, Monelli banditi. Scenari
presenze della giustizia minorile in Italia,
Gangemi editore , Roma 2003
I. Zanier, ed., La scuola nel Veneto.
Storia per immagini, in
FOTOSTORICA - LA RIVISTA, 25/26 (2003)
invia questo articolo a un amico |