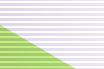Senza Olimpiadi può essere
solo un modo in guerra. Lo dice la storia. Per questo stupisce
la insolita partita di cricket fra Afghanistan e Pakistan di
questi giorni. Due Paesi ufficialmente nemici fra loro. A
conferma che, come è successo molte altre volte, lo sport è
l’ultima spiaggia del dialogo e della convivenza
 Si
ha spesso percezione dello sport come di un insondabile
mistero. Di un qualcosa di così importante nella nostra
storia da sfuggire a qualsiasi categorica definizione.
Millenario specchio delle virtù e dei vizi dell’uomo, lo
sport non è esclusivamente riconducibile alle categorie del
puro agonismo, della vittoria e della sconfitta. C’è dell’altro,
a creare di volta in volta sconcerto ammirazione disagio o
sorpresa, negli eventi che hanno come teatro stadi, strade,
piscine e palestre del mondo. Un indefinibile intreccio di
sensazioni puntualmente ripresentatosi all’indomani dell’attacco
terroristico dell’11 settembre scorso.
Si
ha spesso percezione dello sport come di un insondabile
mistero. Di un qualcosa di così importante nella nostra
storia da sfuggire a qualsiasi categorica definizione.
Millenario specchio delle virtù e dei vizi dell’uomo, lo
sport non è esclusivamente riconducibile alle categorie del
puro agonismo, della vittoria e della sconfitta. C’è dell’altro,
a creare di volta in volta sconcerto ammirazione disagio o
sorpresa, negli eventi che hanno come teatro stadi, strade,
piscine e palestre del mondo. Un indefinibile intreccio di
sensazioni puntualmente ripresentatosi all’indomani dell’attacco
terroristico dell’11 settembre scorso.
Poco più di un mese è stato sufficiente
perché nelle arene sportive di ogni parte del globo sia
accaduto praticamente di tutto. Dalla storica fermata per
lutto del baseball americano (era accaduto solo nel ’44),
alle coppe europee giocate lo stesso all’indomani della
tragedia, alla protesta di Michael Schumacher contro i piloti
intenzionati a correre a Monza senza una partenza lenta
intensa come omaggio alle vittime delle Twin Towers. Episodi
in grado di commuovere, dividere, indignare e interrogare i
cosiddetti "spettatori", ben al di là delle attese
per il nudo e crudo risultato finale.
Qui soffermiamoci pure da quello che è, in
ordine di tempo, l’ultimo evento, ma non per questo il meno
importante. Anzi, è forse il più clamoroso. Ci riferiamo
alla partecipazione della nazionale afgana di cricket al
torneo internazionale di Karachi, nel vicino Pakistan. Succede
cioè che, nel pieno di una devastante e sanguinosa invasione
militare del proprio territorio, lo stesso Afghanistan messo
sotto accusa da parte del Comitato Olimpico Internazionale per
il divieto di fare sport imposto alle donne dalla legge
coranica, invii una rappresentativa a gareggiare nello stato
confinante, diventato ufficialmente nemico dopo l’appoggio
garantito agli Stati Uniti nella guerra contro Osama bin Laden
e la sua rete terroristica di Al Quaida.
Lo stupore può solo aumentare, considerando
come nel Paese dei talebani lo sport totalmente negato al
sesso femminile riservi forti limitazioni anche agli uomini,
che per esempio non possono giocare a scacchi, in quanto la
concentrazione richiesta per muovere alfieri e pedoni
distoglierebbe in modo peccaminoso le menti dalla preghiera
rivolta ad Allah. Sono invece incoraggiati a praticare il
cricket, niente meno che lo sport nazionale dell’odiata Gran
Bretagna, i cui bombardieri affiancano dalla prima ora l’aviazione
americana nei raid quotidianamente compiuti su Kabul e
dintorni.
Quarant’anni di sottomissione alla corona
britannica (1879-1919), e ben tre guerre combattute contro gli
inglesi prima di ottenere una fragile indipendenza con la
salita al trono dell’emiro Aman Ullah, non sono stati dunque
sufficienti per sradicare nel Paese la passione profonda verso
questa disciplina di mazze e guantoni antenata del baseball,
ma rispetto alla sua versione americana ancora più complessa
e difficile da seguire. Impossibile non chiedersi il perché
di questa contraddizione, offerta dallo spettacolo degli
studenti del Corano di bianco vestiti per dedicarsi allo
stesso passatempo prediletto nei più opulenti ed esclusivi
college universitari del Regno Unito. Una prima risposta
arriva in soccorso dalla tormentata storia afgana. Quando
cioè si apprende che il cricket fu una delle più importanti
armi di colonizzazione culturale adottate dai britannici, non
appena ebbero messo sotto il proprio controllo politico questo
Paese di pascoli e pastori incassato tra Cina, ex repubbliche
sovietiche e subcontinente indiano.
In un 1880 apparentemente così lontano dal
nostro presente, delegati e militari di sua maestà usarono lo
sport come insostituibile mezzo rivolto a porre le basi di una
comunicazione culturale con il popolo di una nazione
sottomessa. Il successo della pacifica occupazione praticata
con palline e bastoni, è stato enormemente più grande e
duraturo di quella violenta, imposta dalla forza militare. Al
punto che centoventi anni dopo gli afgani sentono il cricket
come qualcosa di squisitamente proprio. Lo praticano come
disciplina agonistica compatibile con la religione musulmana,
pur avendo avuto origine in una terra di "infedeli".
L’unico totem che il gioco importato dagli
inglesi non è riuscito ad abbattere in Afghanistan rimane
quello dello sport nazionale, il buzkashi, sorta di autoctona
e bellicosa versione del polo, con due squadre di cavalieri
chiamate a contendersi il possesso di una carcassa di capra.
Un rito arcaico, per certi versi "barbarico", che
nei gusti delle masse convive in modo quasi impensabile con i
cerebrali estetismi e le estenuanti raffinatezze tipiche del
cricket.
Sicuramente lontani dalla concezione della
democrazia e dei diritti civili del nemico Occidente, questi
afgani che in piena guerra mandano una nazionale a gareggiare
in Pakistan dimostrano nella pratica dello sport una coerenza
e una dedizione degne di una grande tradizione. La stessa
grande tradizione che nell’Inghilterra del cricket è
rappresentata da tanti esemplari, e a volte eroici atleti,
come il calciatore Bobby Charlton, il mezzofondista Sebastian
Coe, il pilota Jackie Stewart. Campioni che però non sembrano
avere insegnato nulla ai sei miliardari giocatori del Chelsea
di Londra (Desailly, Ferrer, Gallas, Gudjohnsen, Le Saux e
Petit), rifiutatisi di volare fino a Tel Aviv per paura di
attentati terroristici, in occasione della partita di Coppa
Uefa giocata contro l’Hapoel. Col risultato che le loro
riserve hanno puntualmente perso in Israele e che l’immagine
del Chelsea è uscita quanto meno malconcia da una vicenda
nella quale egoismi e paure (queste ultime non
incomprensibili, ma insufficienti) hanno pesato molto più dei
doveri richiesti a strapagati professionisti.
Sport più che mai senza frontiere. Terra di
tutti e di nessuno dove regole, pronostici e aspettative
vengono periodicamente sovvertiti dai più imponderabili
fattori. Sport destinato di volta a trainare, confermare,
contraddire o rivoluzionare gli scenari della politica.
Partite di calcio pacificamente portate a termine fra nazioni
virtualmente in guerra (Inghilterra e Argentina nell’86, all’indomani
delle battaglie alle Falkland, Usa e Iran ai mondiali del ’98),
e altre rese impossibili da odi e rancori che resistono per
decenni (vedi la recente sospensione di un’"amichevole"
tra Francia e Algeria).
Contro preconcetti e muraglie culturali
dalle parvenze insormontabili lo sport dimostra periodicamente
una capacità strabiliante di rovesciare il tavolo, e di
cambiare prospettiva a contesti che sembravano segnati dai
crismi dell’immutabilità. Pochi, solo dieci anni fa,
potevano immaginare che il mistico Tibet dei monaci e dei più
antichi rituali buddisti avrebbe scelto proprio il calcio per
mandare a tutto il mondo un messaggio forte e chiaro sull’isolamento
politico a cui è costretto dal governo cinese. Eppure è
quanto successo la scorsa estate a Copenhagen, dove la
nazionale tibetana ha giocato una storica amichevole con
quella degli esquimesi arrivati dalla Groenlandia. Intento di
entrambe le rappresentative essere ammesse dalla Fifa alle
qualificazioni dei prossimi mondiali, considerati occasione
impagabile di comunicazione ancora prima che di sport.
D’altra parte, che lo sport sia destinato
a rappresentare l’ultima spiaggia del dialogo e della
pacifica convivenza è testimoniato in modo lampante dalla
grande preoccupazione che già assilla gli Stati Uniti in
primo luogo, e tutto il mondo civile di conseguenza: salvare
le imminenti Olimpiadi invernali in programma a Salt Lake
City, in pieno territorio americano. Nessuno si nasconde, a
tre mesi dall’accensione della fiaccola, che le difficoltà
sono quanto meno agghiaccianti, con un tasso di rischio
terroristico reso elevato dalla formidabile concentrazione di
atleti e addetti ai lavori, dall’eccezionale intensità di
viaggi e trasferimenti aerei, e dalla grande esposizione
mediatica destinata all’evento. Ma è altrettanto chiaro
che, come dimostrato dalla storia, senza Olimpiadi può essere
solo un mondo in guerra. E per il terrorismo internazionale
dimostrare questa possibile verità del nostro domani sarebbe
una grande, tremenda vittoria.
Stefano Ferrio